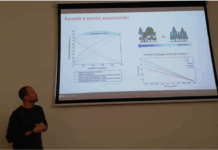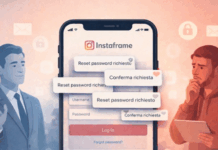Speciali weekend. In un mondo dove la guerra buca gli schermi e riempie le pagine cartacee e web, ma la pace scivola via come una nota stonata in notiziari troppo occupati da esplosioni e sirene d’allarme, non sorprende che quasi nessuno abbia dato spazio alla notizia – storica, potenzialmente epocale – della consegna delle armi da parte dei curdi del PKK in Turchia. Una guerra che durava da quarant’anni, che ha provocato decine di migliaia di morti e devastato intere generazioni, sembra destinata a chiudersi nel silenzio assordante dell’indifferenza mediatica.
Sulla striscia di Gaza, sull’Ucraina, sul Myanmar si aprono finestre quotidiane di approfondimento, comunque più che doverose. Ma quando il rumore delle armi tace, quando il sangue smette (almeno per un istante) di scorrere, la pace sembra non interessare più nessuno.
Eppure, ciò che è appena accaduto nel sud-est anatolico, tra le montagne del Kurdistan turco, merita attenzione quanto – se non più – di un’offensiva militare.
Una guerra tra PKK e Turchia lunga 40 anni
La storia del conflitto tra la Turchia e il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) inizia nel 1984, quando il gruppo fondato da Abdullah Öcalan diede il via a una guerriglia separatista per la creazione di uno stato curdo indipendente. Da allora, la guerra ha visto fasi di tregua, momenti di feroce repressione, attentati e operazioni militari che hanno insanguinato non solo la Turchia, ma anche Siria, Iraq e Iran.
Negli anni il PKK ha cambiato volto, ideologia e strategie: da marxista-leninista a movimento confederale libertario, da lotta per l’indipendenza a rivendicazioni di autonomia culturale e politica. Ma la violenza è rimasta una costante. E lo è stata anche la repressione turca, con decine di migliaia di arresti, villaggi rasi al suolo, leader incarcerati, tra cui lo stesso Öcalan, che da 25 anni è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Imrali.
Il passo che nessuno ha visto: la resa
Alla fine di giugno 2025, con un comunicato trasmesso dalla leadership curda a Qandil, il PKK ha annunciato la consegna simbolica delle armi. Secondo fonti irachene e curde locali, i depositi lungo il confine tra Turchia e Iraq sono stati svuotati e il comando militare ha ricevuto l’ordine di non intraprendere più azioni armate sul suolo turco.
Un gesto senza precedenti, che arriva dopo mesi di negoziati segreti – pare con la mediazione di Iran e Qatar – e che dovrebbe preludere a un accordo politico più ampio, i cui dettagli però restano avvolti da un’ombra di opacità.
Il governo turco, guidato dal presidente Recep Tayyip Erdoğan, ha accolto la notizia con cauta soddisfazione, sottolineando che “la lotta al terrorismo ha vinto”, ma senza promettere nulla in cambio.
Ed è qui che iniziano le domande, i dubbi, i non detti.
Pace o resa unilaterale del PKK?
Tra i punti controversi c’è l’assenza di garanzie pubbliche per i diritti dei curdi in Turchia, né tantomeno un accenno alla possibile liberazione dei leader incarcerati o alla fine dello stato d’emergenza de facto nelle province curde.
L’impressione, per molti analisti, è che si tratti più di una resa che di un accordo di pace. “I curdi hanno scelto la sopravvivenza alla resistenza armata”, dice in forma anonima un ex diplomatico europeo che ha seguito i dossier sulla regione. Le motivazioni, stando alle fonti curde, sono stanchezza, isolamento internazionale e assenza di sponde politiche anche tra le opposizioni turche.
D’altra parte, la mossa potrebbe anche essere un tentativo di aprire una fase nuova, più politica e meno armata, in una Turchia in cui il sogno democratico curdo è stato spinto ai margini, ma non è mai morto.
Ma intanto nessuno ne parla
E qui si torna al punto di partenza: perché la pace o almeno la cessazione del conflitto armato non fanno notizia? Perché la rinuncia alla violenza non ottiene la stessa copertura mediatica di una bomba?
La risposta è amara ma reale: la pace non genera click, non divide, non spacca i talk show, non ha il fascino dell’orrore. Ma è proprio per questo che un giornalismo serio, un’informazione consapevole, dovrebbero avere il coraggio di invertire la rotta.
Raccontare la pace non è buonismo: è riconoscere la fatica del dialogo, il valore del compromesso, la forza della nonviolenza, a volte anche il coraggio dedella rinuncia al “tutto” per avere un minimo da cui ripartire. È dare luce a chi smette di combattere per iniziare a convivere, anche a costo di perdere visibilità, potere, consenso.
E allora, anche se quasi nessuno lo ha detto, oggi una guerra è forse finita. Una notizia che dovremmo scrivere a caratteri cubitali, perché è nella pace che si gioca il futuro, non nei titoli di sangue.