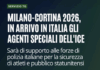In Palestina l’economia è frammentata e spesso paralizzata. Senza banche operative e lavoro stabile, la sopravvivenza passa da aiuti, rimesse dall’estero, debito e scambi informali. Un racconto umano di come si resiste quando il mercato non esiste più.
Palestina assediata: come si vive (e si paga)
Come fanno i palestinesi a procurarsi il denaro necessario per sopravvivere, in territori dove l’economia è soffocata, la mobilità bloccata e il lavoro intermittente o inesistente? È una domanda legittima, che smaschera un equivoco diffuso: l’idea che anche sotto assedio esista comunque una “normalità economica”. In Palestina, semidistrutta e “circondata”, quella normalità non c’è più da tempo.
A Gaza, in particolare, l’economia è stata progressivamente demolita. Le attività produttive sono state distrutte o fermate, le esportazioni quasi azzerate, le importazioni contingentate. Le banche esistono formalmente, ma funzionano a singhiozzo: spesso non c’è contante, i prelievi sono limitati, i pagamenti elettronici inutilizzabili per blackout energetici o mancanza di infrastrutture. Il denaro, quando c’è, non circola.
In Cisgiordania, meno ingabbiata logisticamente, la situazione è diversa ma non meno fragile: checkpoint, chiusure improvvise e restrizioni rendono instabile qualsiasi attività economica. Un lavoro può esserci un mese e sparire quello dopo. La pianificazione è impossibile, l’investimento un azzardo.
Così, la sopravvivenza quotidiana si regge su quattro pilastri precari.
Il primo sono gli aiuti umanitari. Non solo cibo e medicinali, ma anche voucher, piccoli contributi in denaro, carburante, beni essenziali. In un contesto di scarsità, questi aiuti diventano moneta indiretta: ciò che non serve subito può essere scambiato o venduto per ottenere altro. È una micro-economia di necessità, non di profitto.
Il secondo pilastro sono le rimesse dall’estero. Milioni di palestinesi vivono fuori dai territori e inviano denaro alle famiglie rimaste. Senza queste rimesse, in molte case non ci sarebbe da mangiare. Ma anche qui il sistema è fragile: i canali ufficiali sono lenti o bloccati, quelli informali costosi e rischiosi. Ogni trasferimento è una corsa a ostacoli.
Il terzo pilastro è il debito di sopravvivenza. Se possono, il negoziante che segna sul quaderno, il parente che anticipa qualcosa, l’amico che presta pochi contanti. Non è credito bancario, è fiducia sociale. Ma quando la crisi si prolunga, anche questa rete si logora e il debito diventa una catena.
Infine c’è il mercato informale, spesso l’unico mercato possibile. Piccoli scambi, lavori saltuari, riparazioni, trasporti improvvisati. È un’economia invisibile, che non crea sviluppo ma permette di tirare avanti.
In Palestina non si “guadagna” nel senso classico del termine. Si resiste. Ogni giorno. Capire da dove arrivano i soldi significa riconoscere che qui non siamo davanti a un fallimento individuale, ma a un sistema economico reso impossibile. E che, nonostante tutto, la vita continua a cercare spazio.