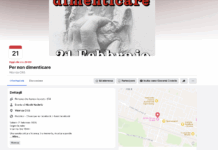Cuba ha dichiarato domenica che 32 suoi cittadini sono morti negli attacchi statunitensi in Venezuela, tra cui personale militare o dell’intelligence, un raro segnale pubblico dell’importanza che Cuba riveste per il Venezuela e per il governo di Nicolás Maduro. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha affermato che le vittime erano membri delle forze armate del Paese o del Ministero dell’Interno che si trovavano in missione su richiesta del Venezuela, secondo quanto riportato dai media statali cubani.
«I nostri compatrioti hanno adempiuto con dignità ed eroismo al loro dovere e sono caduti, dopo una strenua resistenza, in combattimento diretto contro gli attaccanti o a seguito dei bombardamenti sulle installazioni», ha dichiarato Díaz-Canel, annunciando due giorni di lutto nazionale.

La rivelazione rappresenta un’ammissione pubblica eccezionale da parte di Cuba della presenza dei propri agenti nel Paese; il governo di sinistra dell’isola mantiene infatti legami profondi e di lunga data con quello venezuelano.
In un mondo in cui le immagini corrono più veloci delle conferme ufficiali e le dichiarazioni politiche sembrano spesso sovrapporsi alla realtà dei fatti, la verità storica rischia di rimanere imprigionata tra narrazioni contrapposte, calcoli di potere e interpretazioni giuridiche divergenti. La crisi venezuelana esplosa con l’operazione voluta dagli Stati Uniti e la cattura di Nicolás Maduro costituisce un caso paradigmatico di questa difficoltà: non esiste una singola verità oggettiva facilmente estraibile, ma piuttosto una molteplicità di verità parziali, modellate da interessi, ideologie e percezioni differenti.
Dal punto di vista istituzionale, la reazione mondiale all’azione statunitense è stata immediata e profondamente divisiva. Le Nazioni Unite hanno espresso «profonda preoccupazione», denunciando potenziali violazioni della Carta dell’ONU e annunciando una riunione del Consiglio di Sicurezza per discutere la questione. L’assenza di una risoluzione che autorizzi l’uso della forza rende l’operazione incompatibile con i principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare con l’articolo 2, paragrafo 4 della Carta, che vieta l’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato senza autorizzazione esplicita o legittima difesa comprovata.

Queste norme non sono meri testi astratti: affondano le loro radici in secoli di dibattito giuridico e storico sul rapporto tra sovranità statale e uso della forza. Dal XIX secolo in poi, dottrine come quella di Ronald Drago – la cosiddetta Dottrina Drago – sostenevano, con l’appoggio allora degli Usa, che il semplice debito estero non costituisse un motivo legittimo per l’intervento armato di potenze straniere, all’epoca europee, nel continente americano, rappresentando una delle prime sfide teoriche alla pratica interventista.
Parallelamente, la politica estera statunitense ha attraversato diverse fasi, dalla dottrina del “Buon Vicinato” di Roosevelt al Corollario sempre di Roosevelt della Dottrina Monroe, che, contraddicendo in parte il “buon vicinato”, ha legittimato interventi nel continente in nome di un’idea di “polizia internazionale” volta a stabilizzare regioni considerate instabili in funzione degli interessi americani. Queste eredità storiche mostrano come l’uso della forza sia stato spesso giustificato sulla base di concetti oscillanti tra sicurezza regionale, tutela di interessi economici e scontro ideologico.

Nel caso venezuelano, gli Stati Uniti hanno motivato l’azione principalmente con l’accusa di narcoterrorismo e con la necessità di perseguire penalmente Maduro e sua moglie, sostenendo una presunta connessione diretta con attività criminali aventi effetti sul territorio statunitense. Tuttavia, la decisione di intervenire militarmente solleva interrogativi non solo giuridici, ma anche filosofici: fino a che punto uno Stato può agire oltre i propri confini in nome della propria giustizia interna? Qual è il valore reale della sovranità quando una potenza decide che i propri interessi materiali e strategici giustificano mezzi unilaterali?
In questo contesto, la posizione di Cuba appare emblematicamente complessa. L’Avana ha condannato l’intervento statunitense definendolo «terrorismo di Stato» e denunciandolo come una violazione diretta della sovranità venezuelana e dell’integrità della “Nostra America”. Tuttavia, la conferma ufficiale che 32 cittadini cubani, tra militari e agenti di sicurezza, siano morti durante l’operazione rivela la profondità dell’integrazione tra Cuba e le forze del regime chavista e quanto questa relazione sia diventata un elemento sensibile e potenzialmente destabilizzante.
Storicamente, Cuba ha cercato di bilanciare ideali rivoluzionari e necessità pragmatiche dal 1959 in poi, sviluppando una strategia autonoma che include cooperazione scientifica e diplomatica – anche in condizioni di subalternità economica – pur mantenendo legami profondi con altri attori, primo fra tutti il Venezuela. Oggi, però, l’isola si trova in una posizione di forte vulnerabilità: la perdita di personale in un’operazione così controversa la espone contemporaneamente a nuove pressioni economiche, in un momento in cui è già gravata da crisi interne prolungate.
Da una prospettiva filosofica, questa crisi richiama riflessioni profonde sulla natura del potere e sul suo rapporto con la verità. Pensatori come Michel Foucault hanno mostrato come ogni discorso di potere produca un proprio “regime di verità”, ossia un modo di definire ciò che viene accettato come vero in funzione di chi controlla il discorso. Nei conflitti internazionali questa dinamica emerge con particolare evidenza: le narrazioni ufficiali non si contrappongono solo per la loro accuratezza fattuale, ma perché ciascun attore cerca di legittimare il proprio uso della forza e di rendere plausibile una versione dei fatti che rafforzi la propria posizione di potere.

La frammentazione dell’America Latina e la varietà delle reazioni politiche – dalla dura condanna dell’azione americana in Venezuela da parte di Paesi come Brasile e Messico, fino all’approvazione espressa da leader come Javier Milei in Argentina – dimostrano quanto sia difficile costruire una narrazione condivisa o una posizione regionale unitaria. In un mondo multipolare, caratterizzato da bassa fiducia tra Stati e da interessi divergenti, la verità tende a emergere non come un fatto oggettivo, ma come una sintesi negoziata di interessi contrapposti.
In conclusione, più che a una singola verità, oggi assistiamo a un conflitto di narrazioni, ciascuna sostenuta da istituzioni, poteri e storie differenti. La sfida per storici, giuristi e filosofi non è tanto stabilire chi abbia torto o ragione, quanto comprendere come le diverse “verità” si costruiscano all’interno dei conflitti di potere e come esse influenzino le strutture normative e politiche che regolano le relazioni tra gli Stati. In un ordine internazionale sempre più fluido e competitivo, la capacità di far emergere una verità condivisa appare, allo stato attuale, una delle sfide più complesse della nostra epoca.